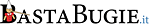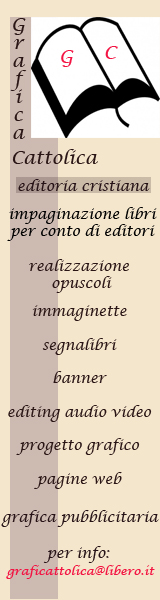Alen Custovic, bosniaco, convertito al cristianesimo e alla scrittura, racconta la violenza che precede ogni conflitto e comincia col vuoto di senso e l’illusione che lo Stato possa creare l’uomo buono
 Come nasce una guerra? Da cosa originano i massacri, le distruzioni, gli stupri, le mille umiliazioni cui essa conduce? Cosa spinge un uomo ad annientarne un altro? Ogni guerra nasce in un modo proprio, irripetibile. Quella di cui mi sento di parlare con più cognizione di causa è quella che ho vissuto in prima persona, a Mostar, fino alla metà del 1993, quando da ragazzino sono giunto in Italia come profugo scappando dalla guerra fratricida della Bosnia ed Erzegovina: 100 mila morti e circa 2 milioni di sfollati, su una nazione che oggi non raggiunge i 4 milioni di abitanti. La guerra è una bestia a cui non ci si abitua mai, nemmeno ai motivi che l’hanno scatenata.
Come nasce una guerra? Da cosa originano i massacri, le distruzioni, gli stupri, le mille umiliazioni cui essa conduce? Cosa spinge un uomo ad annientarne un altro? Ogni guerra nasce in un modo proprio, irripetibile. Quella di cui mi sento di parlare con più cognizione di causa è quella che ho vissuto in prima persona, a Mostar, fino alla metà del 1993, quando da ragazzino sono giunto in Italia come profugo scappando dalla guerra fratricida della Bosnia ed Erzegovina: 100 mila morti e circa 2 milioni di sfollati, su una nazione che oggi non raggiunge i 4 milioni di abitanti. La guerra è una bestia a cui non ci si abitua mai, nemmeno ai motivi che l’hanno scatenata.
Di sicuro però non è un evento che capita dall’oggi al domani. Come il nazismo di Hitler non si strutturò né col Putsch di Monaco né con l’incendio del Reichstag, bensì ancor prima nel sentire della nazione tedesca, così quella in Bosnia ed Erzegovina non scoppiò in seguito al referendum del marzo 1992 sull’indipendenza dalla Federazione jugoslava creata dal maresciallo Tito, perché era già deflagrata nei cuori del popolo di una nazione eterogenea sorretta dall’illusione della religione laicista di Stato.
Don Giussani diceva: «In verità, se uno non nasce da un popolo, cioè se non fiorisce da una realtà sociale naturalmente fondata e organicamente identificata, avrà molta difficoltà per raggiungere una completezza dei suoi fattori». La Bosnia ed Erzegovina non era una realtà organicamente identificata: crollando l’involucro socialista che artificialmente teneva insieme animi diversi, restava un acuto senso di smarrimento, di fallimento esacerbato da un tracollo economico rimandato fino all’agonia di un’inflazione assurda, di una disoccupazione e corruzione inconcepibili.
La guerra nasce da un vuoto di senso. Dostoevskij diceva che «tutta la legge dell’umana esistenza sta in questo: che l’uomo possa inchinarsi all’infinitamente grande». Ecco, in Bosnia d’un tratto pareva non restare più niente, nessun sistema o ideologia a cui rivolgere l’innata ricerca di assoluto. Eppure era terra di grandi tradizioni religiose, di secolari crocevia culturali. All’alba della guerra restavano invece tanti figli di “babbo natale”, come orfani increduli, cresciuti coi pacchi regalo elargiti alla prole dei dipendenti dalle aziende socialiste (tutte), per mezzo del misterioso signore vestito di rosso l’ultimo dell’anno, per conto di uno Stato educatore che aveva instillato nelle menti di generazioni i dettami di una morale intrisa di concetti e princìpi etici altisonanti, ma monchi di sostanza: fratellanza e unità. Inutili perché sempre più privi di testimoni.
 Infatti, era passato ormai un decennio da quando la salma di Tito, morto nel 1980, a bordo di un treno aveva attraversato in lungo e in largo la Jugoslavia, quasi un disperato monito all’unità, ricevendo l’ultimo commosso saluto di una popolazione che inconsciamente presagiva il futuro di una terra che pochi come lo scrittore Ivo Andric hanno descritto: «I vizi dovunque generano l’odio, perché consumano e non creano, ma nei paesi come la Bosnia, anche le virtù spesso parlano e si esprimono attraverso l’odio». Fu il decennio in cui si gettarono le basi degli orrori che sarebbero seguiti. Il nazionalismo esplose come un’epidemia inarrestabile, alimentato da oscuri personaggi come Slobodan Milosevic (ma non solo), che iniziarono a cavalcare il malcontento diffuso.
Infatti, era passato ormai un decennio da quando la salma di Tito, morto nel 1980, a bordo di un treno aveva attraversato in lungo e in largo la Jugoslavia, quasi un disperato monito all’unità, ricevendo l’ultimo commosso saluto di una popolazione che inconsciamente presagiva il futuro di una terra che pochi come lo scrittore Ivo Andric hanno descritto: «I vizi dovunque generano l’odio, perché consumano e non creano, ma nei paesi come la Bosnia, anche le virtù spesso parlano e si esprimono attraverso l’odio». Fu il decennio in cui si gettarono le basi degli orrori che sarebbero seguiti. Il nazionalismo esplose come un’epidemia inarrestabile, alimentato da oscuri personaggi come Slobodan Milosevic (ma non solo), che iniziarono a cavalcare il malcontento diffuso.
“Profetico” fu il discorso che Milosevic tenne nel 1989, in occasione del seicentesimo anniversario della storica battaglia della Piana dei Merli (Kosovo Polje), combattuta dall’esercito serbo contro quello ottomano: «L’eroismo del Kosovo ha ispirato la nostra creatività per sei secoli, e ha nutrito il nostro orgoglio e non ci consente di dimenticare che un tempo fummo un esercito grande, coraggioso, ed orgoglioso, uno dei pochi che non si potevano vincere nemmeno nella sconfitta». Era già lì, anticipata, la lucida follia che avrebbe guidato le mani insanguinate di tutti gli schieramenti, dando adito a un risentimento che covava dentro da generazioni e generazioni.
Gli occhi di un bambino
Ma se questa è un’analisi a posteriori, attraverso gli occhi di un fanciullo, la guerra si chiama innanzitutto insicurezza, lo stravolgimento di ogni tipo di relazioni. A cominciare dalla scuola, le cui attività da singhiozzanti si interruppero del tutto, dopo che fu centrata da una delle migliaia di granate che cominciarono a precipitare incessantemente dal cielo. Già prima, come tutti i ragazzini che crescendo si affacciano fuori dal proprio quartiere, sempre più ci spostavamo verso la periferia della città dove comparvero posti di blocco. Prima la polizia, poi l’esercito regolare e infine paramilitari sinistri dall’accento strano. Non capivamo. Camion e jeep ai lati, carri armati in mezzo alla strada; facce torve che intimano l’alt, chiedono documenti, scherniscono chi porta il nome di un’altra fede.
Il tutto in un paese in cui l’unico dogma era quello del socialismo applicato trasversalmente in ogni ambito della società. Ma in quei visi feroci, fino a ieri ostentatamente votati agli egualitarismi e tesserati nell’unico partito, che militavano in comizi e spandevano il credo della “fratellanza e uguaglianza”, non c’era più traccia di tutto ciò. Le barbe incolte avevano coperto “il compagno” di prima; antichi stemmi razziali issati sui copricapi, aquile, croci e mezzelune, avevano rimpiazzato la stella rossa dei partigiani canonizzata per legge da Tito dopo la vittoria sul nazifascismo.
Quegli uomini infiammati dall’alcol che ribolliva dentro ventri troppo grossi per quelle divise ancora nuove dell’esercito federale della Jugoslavia ardevano per affermare, ognuno per la sua fazione, una superiorità etnica e morale, fino ad arrivare al genocidio di massa. Erano uomini mediocri, ma la storia insegna che proprio questi sono in grado di prenderne le redini; la stessa gente che incarnava quella “banalità del male” raccontata da Hannah Arendt decenni prima rimuginando sulla brutalità dell’eccidio nazista, dove il male tra i suoi servitori non ha visto i demoni ma grigi burocrati. Tecnici in grado come pochi di piombare l’esistenza altrui. Vicini di casa trasformati in carnefici.
Nel nascere di una guerra, e di qualsivoglia spirito d’appartenenza, importantissimi sono i simboli che incarnano le idee. La Bosnia di inizio anni Novanta era diventata un supermarket della simbologia. Sulla montagna che sovrasta la città di Mostar, prima della guerra era riportata una gigantesca scritta: «Tito volimo te» (Tito ti amiamo), sostituita oggi da «BiH volimo te» (Bosnia ed Erzegovina ti amiamo); un cambiamento paradigmatico del comune sentire.
Così dalle mille varianti di stemmi e fiamme incorniciate a falce e martello e la mitizzazione dei salvatori della patria, attraversando un insostenibile vuoto di senso dove anche i più coriacei precetti comunisti vacillavano, si passò velocemente ai rosari e ai tasbeeh islamici, ai crocefissi e alle mezzelune verdi. Solo che ciondolavano appesi attorno al caricatore dei proiettili, imbrattati sul calcio di un kalashnikov o sulle fasce che cingevano le fronti di improbabili Rambo. D’un tratto schiere di neofiti cominciarono a battersi le mani sul petto, ognuno per il suo branco, rimpiazzando il credo marxista con un’adesione di superficie ai nomi di Cristo e Maometto il Profeta, insultandoli, perché presero ad ammazzare invocando i loro nomi; il tutto veicolato da un linguaggio nuovo, caustico e sdegnoso del passato.
 Le “profezie” della tv
Le “profezie” della tv
La tv di Stato catalizzava l’audience con sceneggiati che profetavano la fine della Jugoslavia e per strada ad ogni angolo si raccontavano barzellette che irridevano gli altri. Presto sarebbe crollato tutto sotto il tuono dell’artiglieria pesante e degli inni di battaglia di secoli addietro, che rievocavano antichi eroi epici e una grigia malinconia del “si stava meglio prima” che cominciò ad attraversare le menti degli uomini, tanto velocemente che il nazionalismo presto cedette il passo allo sciovinismo puro.
Chi scrive ha incarnato l’ultima generazione dei “pionieri di Tito”, partecipando con tutti i coetanei ad un rito collettivo previsto dal programma scolastico, che consisteva nel seguente giuramento: «Oggi che divento un pioniere do la mia parola di pioniere che studierò e lavorerò con impegno, e che sarò un buon compagno; che amerò la nostra patria autogestita la Repubblica Socialista Federale Jugoslava. Che contribuirò nello sviluppo della libertà e della fratellanza e delle idee per le quali ha lottato Tito; che rispetterò tutti i popoli del mondo che amano la libertà e la pace».
Nello stesso modo negli anni avevano giurato intere generazioni di pionieri, si erano issate sul copricapo blu la stella rossa e sulle spalle il foulard rosso come il sangue dei partigiani versato per edificare la nuova impalcatura sociale, proterva quanto evanescente. Ecco, la guerra origina anche in questo, nel disprezzo del presente.
Ma quali sono i risultati a cui essa ha condotto questo paese? Oggi la Bosnia è molto cambiata, in peggio. Un’economia collettivista implosa su se stessa, mutata nell’opposto della sua stessa origine: un capitalismo selvaggio che raccoglie una disoccupazione del 50 per cento. E la guerra? È solo assopita, perché l’odio o lo sradichi del tutto o ricresce da sé.
Più che pace c’è una tregua apparente, calmierata dalla forza militare internazionale e dalle sponsorizzazioni dei loro governi. Una nazione in cui sono poche le famiglie che non piangono un morto, il cui sangue bolle ancora nei vivi per l’esito del conflitto stesso: una repubblica, la Bosnia ed Erzegovina, divisa a sua volta in due realtà, la Repubblica serba e la Federazione croato-musulmana. Un caso unico al mondo, così complesso nel suo apparato di funzionamento ideato per garantire un equilibrio precario da condannarlo il più delle volte all’immobilità.
La guerra nasce anche dalla dimenticanza. Nel Levitico c’è scritto: «Onora la faccia del vecchio». E Israele è da sempre invitato allo Shemà, ad ascoltare. Ma ascoltare si può solo se si fa memoria viva di ciò che ci costituisce. Nella Bosnia di allora non c’era più niente da onorare e poco in cui credere. Il sistema era fondato su un’illusione ontologica: aveva la pretesa di rivestire lo Stato del potere di creare l’uomo buono, moralmente integerrimo, esclusivamente per mezzo della legge. Non aveva fatto i conti con la caratteristica prima dell’uomo: la libertà.
Il pensiero all’Italia in tempesta
Una tentazione che puntualmente ritorna, anche nell’Italia di oggi “senza nocchiero in gran tempesta” come forse mai nella sua storia repubblicana. No. Non è possibile insufflare nell’uomo la bontà e il rispetto del prossimo per mezzo del diritto positivo o di princìpi etici privi di adesione volontaria. È una tentazione pericolosa che può condurre molto in basso.
Ma la guerra non è solo quella delle armi. Ce n’è una più strisciante, subdola perché non dichiarata. È quella che coltiva la cultura del sospetto, della denuncia del prossimo, la messa alla gogna a priori di ciò che è altro; che crea indifferenza. E non c’è credo, nazionalismo o convinzioni politiche che tengano davanti al disprezzo dell’altro tanto da volerlo annientare.
La guerra nella Bosnia ed Erzegovina può essere in questo senso letta come una tragica allegoria della natura umana, perché la guerra ancor prima che sui campi di battaglia nasce dall’ineducazione e dall’inedia del dialogo vissuto, che non può che passare dalla famiglia, dalla scuola, dai gruppi sociali, perché solo in questo modo si concretizza la tensione verso la vera pace e la riconciliazione di un popolo non resta un discorso frivolo; perché incarnato nelle persone.
Fonte: La guerra di Tito e l’illusione di ricreare l’uomo nuovo | Tempi.it.