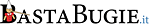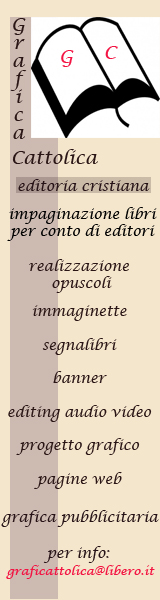di Giorgio Bernardelli 03-06-2013
«Vogliamo essere Istanbul e non Doha». Tra le tante immagini di questi giorni sulle proteste in piazza Taksim, forse è proprio questo cartello a riassumere meglio di tutto il resto quanto sta accadendo in Turchia. Nello scontro iniziato intorno al Gezi Park – il giardino nella piazza più importante della Istanbul moderna che dovrebbe sparire per lasciare spazio all’ennesimo centro commerciale – per la prima volta appare seriamente in discussione l’intero modello incarnato dal premier Racep Tayyip Erdogan e dal suo partito l’Akp. Stanno cioè venendo al pettine le contraddizioni del modello islamico che – nella primavera 2011 – era stato indicato come lo sbocco naturale delle rivolte che avevano spazzato via figure come Ben Ali e Mubarak. Erdogan appariva come l’icona di un islam moderno e (soprattutto) di successo, che va al potere con elezioni vinte democraticamente e inanella tassi di crescita mirabolanti, esporta prodotti in tutto il Medio Oriente, dal manifatturiero alle telenovela che fanno cultura nel mondo arabo. Nelle analisi geopolitiche si era tornati così a parlare di neo-ottomanesimo, anche sulla scia di una politica estera molto intraprendente che la Turchia aveva cominciato a mettere in campo (e di cui il duro scontro con l’ex alleato Israele era diventato un grande simbolo).
Tutto questo era fino a ieri la Turchia di Erdogan, quella per cui il 2013 sarebbe dovuto essere l’anno della definitiva consacrazione a settembre, quando è attesa l’assegnazione delle Olimpiadi del 2020 che tutti pronosticano a Istanbul. Non che non possa succedere ancora, ovviamente. Però quanto sta accadendo in queste ore in piazza Taksim rivela come le basi del modello siano molto più fragili di quanto si volesse far credere. Ed è molto interessante che la miccia che ha innestato le proteste sia stata proprio un piano per costruire l’ennesimo centro commerciale: non c’è simbolo più potente per la Istanbul di oggi. La città sul Bosforo è quella dove strutture di questo tipo negli ultimi dieci anni sono sputate come funghi. Nella parte asiatica si progetta addirittura di costruire una terza Venezia, dopo quella sulla Laguna e quella di Las Vegas. È l’islam degli affari quello che Erdogan ha incarnato, nel segno di una borghesia anatolica per la quale il volto della moderazione è sostanzialmente funzionale all’ingresso nei salotti buoni dell’economia internazionale. Solo che sotto restavano le contraddizioni irrisolte: prima tra tutte quella di un equilibrio ancora tutto da trovare tra il nuovo corso islamista e la tradizione laica imposta da Ataturk. Senza dimenticare che – accanto all’eterno problema dello scontro tra religiosi e laici – c’è anche la questione dell’autoritarismo che neanche il volto moderno della Istanbul degli affari riesce fino in fondo a nascondere: perché la Turchia è tuttora uno dei Paesi al mondo con il maggior numero di giornalisti in carcere (sabato sera mentre divampavano le manifestazioni le tv trasmettevano programmi di cucina e documentari sui delfini). E la repressione violenta di una manifestazione di protesta da parte della polizia a Istanbul non è una grossa novità.
C’è però anche un altro fattore che oggi gioca decisamente contro Erdogan ed è la guerra nella vicina Siria. La Turchia è il Paese che ha più da perdere nel perdurare del conflitto. Non solo per il numero di profughi che continua a crescere nelle aree di confine, ma soprattutto per i contraccolpi interni che sta subendo rispetto alla questione storicamente delicatissima (e tuttora irrisolta) del rapporto con le minoranze. La forza dell’Impero Ottomano era stata proprio la capacità di inclusione. Ma andò in crisi quando – in nome di una modernizzazione nazionalista – all’inizio del Novecento i giovani turchi imposero la loro sanguinosa soluzione con gli esiti drammatici che conosciamo per armeni e assiri. Nella Turchia di Erdogan – non più forzatamente laicizzata – inevitabilmente la questione delle minoranze è riaffiorata con il volto soprattutto degli alevi e dei curdi (le minoranze non cristiane sopravvissute). E il nuovo modello turco ha anche provato la strada dell’inclusione (ad esempio con le trattative con i curdi); ora, però, il vento in arrivo dalla Siria lo sta portando da tutt’altra parte. Ed anche le mire internazionali di Erdogan stanno finendo schiacciate da nuove potenze in ascesa come – appunto – il Qatar, il grande finanziatore dei gruppi armati in Siria.
In evidente difficoltà l’uomo forte di Istanbul ha provato a giocare di nuovo la carta dell’islam. Così la scorsa settimana ha fatto approvare dal Parlamento una legge che limita la vendita degli alcolici. Ma – in una realtà dagli equilibri complessi come quella turca – niente più di un simbolo come questo poteva contribuire ad accentuare le polarizzazioni. E a far sorgere domande sulla direzione verso cui sta camminando davvero il Paese. Al di là degli slogan scanditi in piazza, probabilmente Erdogan non sta ancora vacillando. Ma per la prima volta la piazza gli chiede conto delle sue scelte: ha in mente Istanbul – con tutto ciò che questo comporta anche in termini di incontro vero tra Oriente e Occidente – oppure semplicemente una Doha molto più grande e con giusto qualche monumento ottomano salvato in mezzo ai terminal per nuovi ricchi? È il bivio di fronte al quale l’Akp prima o poi dovrà scegliere davvero.