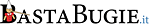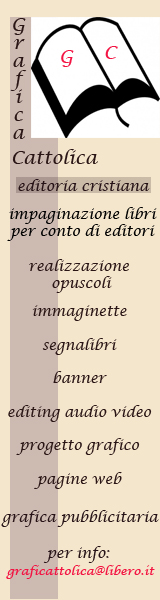di Roberto Martinelli
Segretario generale aggiunto del SAPPE – Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria
Era la fine del 2003 quando gli organi di informazione si occupavano di una fino ad allora inedita denuncia del SAPPE: la cella poteva diventare luogo di potenziali conversioni religiose favorendo il fondamentalismo islamico. Scrivemmo, riprendendo un articolo apparso proprio su questa Rivista, che le allora crescenti tensioni tra civiltà islamica e cristiana potevano avere risvolti inquietanti anche all’interno delle carceri italiane, considerato l’alto numero di detenuti di fede islamica (soprattutto – ma non solo – extracomunitari). Da tempo rappresentavamo le nostre preoccupazioni circa le avvenute diverse conversioni, in carcere, di detenuti italiani all’Islam. Per molti diseredati, che a causa delle loro azioni sono stati puniti dalla società in cui vivono e sono nati, può risultare atto di emenda abbracciare un nuovo credo e così avviare una facile via per la costruzione di una nuova identità sociale, favorita dall’idealizzazione di cui viene a godere tale atto: attribuendo al nuovo credo la capacità di riconoscere un valore a tutto ciò che la società di provenienza sanzione. Così ogni diseredato ben indottrinato può facilmente autoassolversi per il proprio essere deviante per il solo fatto di vedersi riconosciuto un “ruolo” all’interno della nuova società in cui entra abbracciandone il credo e lottando per Allah. Era già accaduto nel passato: un pregiudicato siciliano, convertitosi all’Islam in carcere dov’era detenuto per reati minori, fece esplodere due bombole di gas nel metrò di Milano (11 maggio 2002) e nei templi della Concordia di Agrigento (5 novembre 2001). Allora, come ora, i nostri istituti di pena ospitavano ed ospitano una popolazione detenuta di origine extracomunitaria estremamente vasta, variegata, rabbiosa e soprattutto sconosciuta. Una successiva interessante ricerca di Mohammed Khalid Rhazzali, dottore di ricerca in Sociologia dei processi comunicativi e interculturali presso l’Università di Padova, ci aiutò ad affrontare (sette anni dopo la nostra denuncia, nel 2010) il tema dell’esperienza religiosa dei musulmani nelle prigioni italiane, concentrandosi in particolar modo sulla ricostruzione dei modi in cui la religione opera nella dimensione soggettiva del detenuto, favorendo una possibilità di ricostituzione di un’autostima e una nuova affermazione identitaria. Lo studio accerterà che nel carcere i musulmani sembrano incontrare la replica esasperata del loro essere in quanto immigrati costretti in uno spazio caratterizzato da regole e da logiche estranee alla loro cultura di provenienza e spesso non facilmente mediabili con la spontaneità del loro comportamento. La religione quindi si presenta al musulmano che vive una condizione di avvilimento, di sconfitta esistenziale e di mortificazione nell’istituzione totale come una possibilità di ricostituzione di un’autostima, e come accesso a una ritrovata esperienza d’ordine nell’organizzazione della vita, oltre che ovviamente ma anche problematicamente come affermazione identitaria. Scrivemmo, sempre nel 2005 e possiamo confermarlo anche oggi, che di pochi di questi detenuti stranieri si conoscevano i reali collegamenti con l’esterno: ma non solo, questi soggetti facevano e fanno della comune situazione di detenzione un valido strumento di predicazione verso i soggetti più deboli e diseredati ristretti con loro. Per un musulmano, infatti, è più importante la religione della nazionalità. I musulmani credono di essere legati dalla loro fede comune all’interno di un’unica comunità – la umma – in cui tutti sono “fratelli l’uno dell’altro“. Questo spiega quella solidarietà particolare che l’Islam crea, al di là dei limiti di frontiera. Ma i fondamentalisti di tutte le religioni hanno caratteristiche comuni: tutti interpretano i simboli alla lettera. Sono altamente selettivi sui “fondamenti” che scelgono di rispettare e sulle porzioni di modernità da tollerare. Tutti fanno riferimento a testi tradizionali e li usano fuori dal loro contesto. Tutti praticano forme di manicheismo, vedendo se stessi come parte di una battaglia cosmica tra il bene e il male in cui devono trovare gli oppositori e demonizzarli. In tale contesto, denunziammo come la cella poteva diventare il luogo in cui, sempre più spesso, piccoli criminali erano tentati da membri di organizzazione terroristiche detenuti. Del resto, già nel nostro recente passato le Brigate Rosse avevano inteso le carceri quali luoghi di lotta e proselitismo. Analogo stratagemma veniva messo in atto dagli esponenti del terrorismo islamico, i quali cercano così di mimetizzare la propria attività infiltrando propri adepti fedeli e non sospetti, in quanto occidentali. Auspicammo, in conclusione, un necessario sforzo formativo dell’Amministrazione penitenziaria teso a dare gli strumenti tecnico-cognitivi alla Polizia Penitenziaria per incrementare la propria professionalità, adattando le competenze e i metodi esistenti con nuovi standard operativi, in modo da trattare tali situazioni senza prescindere dalla diverse culture che si incontrano all’interno del carcere, e rivendicano come le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria potevano giocare un ruolo di primaria importanza all’interno dell’opera di prevenzione di tali fenomeni dal fronte delle carceri.
Quasi dieci anni dopo quella denuncia, una importante pubblicazione a cura dell’Issp (Istituto superiore di studi penitenziari) torna a denunciare come dietro le sbarre cresca il proselitismo islamico. A evidenziarlo è lo studio ‘La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere’, condotto dal magistrato Francesco Cascini, direttore dell’Ufficio per l’attività ispettiva e di controllo presso il DAP e da alcuni vice commissari che hanno partecipato al 2° corso di formazione dell’Issp. Dalla ricerca, emerge una situazione allarmante -descritta dall’Europool e da altri osservatori europei- nel Regno Unito dove la radicalizzazione avviene grazie all’influenza di altri detenuti o i colloqui con familiari e visitatori autorizzati per l’assistenza religiosa. Negli istituti di pena londinesi risulta che molti detenuti non musulmani siano stati costretti, con la violenza fisica, a convertirsi all’Islam, a non consumare carne di maiale e a seguire i dettami della sharia. E proprio in un carcere inglese Richard Reid, cittadino britannico, si convertì all’islam ”e iniziò la sua formazione terroristica che lo portò ad addestrarsi in Afghanistan e in Pakistan e, infine, nel dicembre 2001, a tentare di far esplodere un aereo in rotta verso Miami imbarcandosi con polvere e detonatore nascosti nelle scarpe. Ma anche in Italia, evidenzia il rapporto, esistono casi analoghi, sia pure meno eclatanti, e si cita il già ricordato caso di Domenico Quaranta, convertito all’islam nel penitenziario di Trapani e autore di attentati incendiari ad Agrigento ed all’interno della metrò di Milano, oggi riconosciuto imam dai detenuti accusati di terrorismo internazionale nel carcere dell’Ucciardone dove si trova. Il ‘Quaderno’ documenta anche i risultati di un monitoraggio avviato dall’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo che, dopo aver individuato tre figure ricorrenti tra gli islamici praticanti (i leader e/o conduttori di preghiera, i promotori della creazione nelle carceri locali di incontro tra detenuti di fede islamica; i partecipanti agli incontri), elabora un indice di ‘attenzionabilità‘ e, dallo studio delle ordinanze di custodia cautelare, desume che la maggior parte dei leader appartenevano ai gruppi terroristici Gspc (Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento), Gicm (Gruppo Islamico Combattente Marocchino), Al Quaeda e Hamas. L’islamizzazione in senso jihdaista passa prima attraverso la radicalizzazione, il rifiuto integrale dell’Occidente, e trova terreno fertile in individui fragili che ”cercano nell’Islam una tregua da un passato inquieto e credono che alcune azioni, come ad esempio la partecipazione ad un attentato suicida, possano offrire un’opportunità per la propria salvezza e perdono”. Molti detenuti, duqnue, abbracciano l’Islam per essere accettati nella comunità di individui che sono già musulmani e per acquisire/consolidare un’identità. Quasi tutti prima della conversione conoscono poco o affatto la religione islamica. Prevenire il proselitismo significa dunque in primo luogo riconoscere il fenomeno della radicalizzazione violenta, aspetto che pone un problema di formazione specifica del personale europeo, penalizzato dalla barriera linguistica e dalla profonda diversità culturale. Nel ‘Quaderno’ si approfondiscono anche aspetti specifici riguardanti il trattamento e la sicurezza come l’Islam e il ruolo della donna operatrice penitenziaria’ (Aureliana Calandro), il ruolo del ministro di culto islamico (Nadia Giordano), la gestione della socialità (Giovanni La Sala), la vigilanza della Polizia Penitenziaria sui detenuti di matrice terroristica radical religiosa (Salvatore Parisi), gli strumenti della prevenzione (Melania Quattromani), la gestione penitenziaria e la devianza criminale (Giuseppe Simone), le azioni di contrasto del fanatismo islamico (Pasquale Spampanato). Sarebbe ora auspicabile che la pubblicazione non resti una letture d’elitè ma venga quanto più possibile diffusa tra il personale di Polizia Penitenziaria, favorendo con l’occasione momenti di aggiornamenti professionali sulla delicata materia.